In questo articolo, estratto dal libro “Il dono della terapia“, Irvin Yalom fornisce approfondimenti sul ruolo del terapeuta nel rimuovere gli ostacoli nella terapia e come compagno di viaggio.
Rimuovere gli ostacoli alla crescita
Quando stavo cercando la mia strada come giovane studente di psicoterapia, il libro più utile che ho letto è stato Neurosis and Human Growth di Karen Horney. E l’unico concetto più utile in quel libro era l’idea che l’essere umano abbia una propensione intrinseca all’autorealizzazione. Se gli ostacoli vengono rimossi, credeva Horney, l’individuo si svilupperà in un adulto maturo e pienamente realizzato, proprio come una ghianda si svilupperà in una quercia.
“Proprio come una ghianda si sviluppa in una quercia.” Che immagine meravigliosamente liberatoria e chiarificatrice! Ha cambiato per sempre il mio approccio alla psicoterapia offrendomi una nuova visione del mio lavoro: il mio compito era rimuovere gli ostacoli che bloccavano il percorso del mio paziente. Non dovevo fare l’intero lavoro. Non dovevo ispirare nel paziente il desiderio di crescere, la curiosità, la volontà, la gioia di vivere, la cura, la lealtà o una qualsiasi delle miriadi di caratteristiche che ci rendono pienamente umani. No, quello che dovevo fare era identificare e rimuovere gli ostacoli alla buona riuscita della terapia. Il resto sarebbe seguito automaticamente, alimentato dalle forze di autorealizzazione all’interno del paziente.
Il caso della giovane vedova
Ricordo una giovane vedova con, come diceva lei, un “cuore fallito“, un’incapacità di amare ancora. Era scoraggiante affrontare l’incapacità di amare. Non sapevo come farlo. Ma dedicarmi ad identificare e a sradicare i suoi tanti blocchi verso amore? Quello potevo farlo.
Ho imparato presto che l’amore le sembrava un tradimento. Amare un altro significava tradire il marito morto; le sembrava di battere gli ultimi chiodi nella bara di suo marito. Amare un altro così profondamente come faceva con suo marito (e lei non si sarebbe accontentata di niente di meno) significava che il suo amore per suo marito era stato in qualche modo insufficiente o imperfetto. Dare il proprio amore ad un altro sarebbe stato autodistruttivo perché la perdita e il dolore lancinante della perdita erano inevitabili. Amare di nuovo era irresponsabile: sarebbe stato malvagio, e il suo bacio sarebbe stato il bacio della morte.
Lavorammo duramente per molti mesi per identificare tutti questi ostacoli verso il suo amore per un altro uomo. Per mesi lottammo a turno con ogni ostacolo irrazionale. Ma una volta fatto ciò, i processi interni della paziente presero il sopravvento: incontrò un uomo, si innamorò, si risposò. Non dovetti insegnarle a cercare, a dare, ad amare. Non avrei saputo come farlo.
Evita la diagnosi
Gli studenti di psicoterapia di oggi sono esposti a troppa enfasi sulla diagnosi. Si richiede che i terapeuti arrivino rapidamente a una diagnosi precisa e quindi procedano con un corso di terapia breve e mirata che corrisponda a quella particolare diagnosi. Suona bene. Sembra logico ed efficiente. Ma ha poco a che fare con la realtà. Rappresenta invece un tentativo illusorio di legiferare sulla precisione scientifica quando non è né possibile né desiderabile.
Sebbene la diagnosi sia indiscutibilmente critica nelle considerazioni sul trattamento per molte condizioni gravi con un substrato biologico (ad esempio schizofrenia, disturbi bipolari, disturbi affettivi maggiori, epilessia del lobo temporale, tossicità da farmaci, malattie organiche o cerebrali da tossine, cause degenerative o agenti infettivi) la diagnosi è spesso controproducente nella psicoterapia quotidiana di pazienti con disabilità meno gravi.
Perché? Per prima cosa, la psicoterapia consiste in un processo che si sviluppa gradualmente in cui il terapeuta cerca di conoscere il paziente nel modo più completo possibile. Una diagnosi limita la vista, diminuisce la capacità di relazionarsi con l’altro come persona. Una volta fatta una diagnosi, tendiamo a disattendere selettivamente gli aspetti del paziente che non rientrano in quella particolare diagnosi, e corrispondentemente prestiamo attenzione eccessiva alle caratteristiche sottili che sembrano confermare una diagnosi iniziale.
Inoltre, una diagnosi può agire come una profezia che si autoavvera. Riferirsi a un paziente come un “borderline” o un “isterico” può servire a stimolare e perpetuare proprio questi tratti. In effetti, c’è una lunga storia di influenza iatrogena sulla forma delle entità cliniche, inclusa l’attuale controversia sul disturbo di personalità multipla e sui ricordi repressi di abuso sessuale. E tenete presente anche la scarsa affidabilità della categoria dei disturbi di personalità del DSM (gli stessi pazienti spesso impegnati in psicoterapia a lungo termine).
Terapia e diagnosi
E quale terapeuta non è rimasto colpito da quanto sia più facile fare una diagnosi dal DSM-IV dopo il primo colloquio che dopo, diciamo, la decima seduta, quando sappiamo molto di più sull’individuo? Non è uno strano tipo di scienza? Un mio collega porta questo punto a casa ai suoi ospiti psichiatrici chiedendo: “Se tu fossi in psicoterapia personale o lo stessi prendendo in considerazione, quale diagnosi DSM-IV pensi che il tuo terapeuta potrebbe legittimamente usare per descrivere qualcuno complicato come te?” (C. P. Rosenbaum, comunicazione personale, novembre 2000).
Nell’impresa terapeutica dobbiamo tracciare una linea sottile tra una certa, ma non troppo, oggettività; se prendiamo troppo sul serio il sistema diagnostico del DSM, se crediamo davvero che stiamo davvero scolpendo le articolazioni della natura, allora potremmo minacciare la natura umana, spontanea, creativa e incerta dell’avventura terapeutica. Ricordate che i medici coinvolti nella formulazione di sistemi diagnostici precedenti, ora scartati, erano competenti, orgogliosi e altrettanto fiduciosi quanto gli attuali membri dei comitati DSM.
Euforia e oscurità della vita
Andrè Malraux, il romanziere francese, descrisse un prete di campagna che si era confessato per molti decenni e riassunse in questo modo ciò che aveva imparato sulla natura umana: “Prima di tutto, le persone sono molto più infelici di quanto si pensi… e non esiste la persona adulta“. Tutti, compresi i terapeuti e i pazienti, sono destinati a sperimentare non solo l’euforia della vita, ma anche la sua inevitabile oscurità: disillusione, invecchiamento, malattia, isolamento, perdita, mancanza di significato, scelte dolorose e morte.
Nessuno ha messo le cose in modo più netto e cupo del filosofo tedesco Arthur Schopenhauer:
“Nella prima giovinezza, mentre contempliamo la nostra vita futura, siamo come bambini in un teatro prima che il sipario si alzi, seduti lì di buon umore e in trepidante attesa che inizi lo spettacolo. È una benedizione che non sappiamo cosa succederà veramente. Possiamo prevederlo, ci sono momenti in cui i bambini possono sembrare prigionieri condannati, condannati non a morte, ma a vita, e ancora del tutto inconsapevoli del significato della loro condanna.”
O di nuovo:
“Siamo come agnelli nei campi, che si agitano sotto gli occhi del macellaio, che ne sceglie prima l’uno e poi l’altro per la sua preda. Così è che nei nostri giorni buoni siamo tutti inconsapevoli del male che il destino può avere attualmente in serbo per noi: malattia, povertà, mutilazione, perdita della vista o ragione.”
La vita tra felicità e disperazione
Sebbene il punto di vista di Schopenhauer sia fortemente influenzato dalla sua personale infelicità, è tuttavia difficile negare la disperazione insita nella vita di ogni individuo autocosciente.
Mia moglie ed io a volte ci siamo divertiti ad organizzare cene immaginarie per gruppi di persone che condividono propensioni simili, ad esempio una festa per monopolisti o narcisisti fiammeggianti o astuti aggressivi passivi che abbiamo conosciuto o, al contrario, una festa “felice” a cui invitiamo solo le persone veramente felici che abbiamo incontrato. Anche se non abbiamo avuto problemi a riempire tutti i tipi di altri tavoli stravaganti, non siamo mai stati in grado di popolare un tavolo completo per la nostra festa di “gente felice“. Ogni volta che identifichiamo alcune persone caratterologicamente allegre e le mettiamo in una lista d’attesa mentre continuiamo la nostra ricerca per completare il tavolo, scopriamo che uno o l’altro dei nostri ospiti felici è alla fine colpito da alcune grandi avversità della vita, spesso una grave malattia o quella di un figlio o coniuge.
Terapeuta e paziente come “compagni di viaggio” nella terapia
Questa visione tragica ma realistica della vita ha a lungo influenzato il mio rapporto con coloro che cercano il mio aiuto. Ci sono molti termini per descrivere la relazione che si crea nella terapia:
- paziente/terapeuta;
- cliente/consulente;
- analizzato/analista;
- cliente/facilitatore;
- utente/fornitore (a mio parere il più ripugnante).
Tuttavia nessuna di queste frasi trasmette accuratamente il mio senso della relazione terapeutica. Preferisco invece pensare a me e ai miei pazienti come compagni di viaggio all’interno della terapia. Questo termine abolisce la distinzione tra “loro” (gli afflitti) e “noi” (i guaritori).
Durante la mia formazione sono stato spesso esposto all’idea del terapeuta completamente analizzato. Ma man mano che sono progredito nella vita, ho stretto relazioni intime con molti dei miei colleghi terapeuti, incontrato le figure più importanti del campo, sono stato chiamato a prestare aiuto per i miei ex terapeuti e insegnanti, e io stesso diventato un insegnante e un anziano, sono arrivato a realizzare la natura mitica di questa idea. Siamo tutti insieme in questo e non c’è nessun terapeuta e nessuna persona immune dalle tragedie intrinseche dell’esistenza.
Il racconto dei due guaritori
Uno dei miei racconti preferiti di guarigione, che si trova nel Magister Ludi di Hermann Hesse, coinvolge Joseph e Dion, due rinomati guaritori, vissuti in tempi biblici. Sebbene entrambi fossero molto efficaci, funzionavano in modi diversi. Il giovane guaritore, Joseph, guariva attraverso un ascolto silenzioso e ispirato. I pellegrini si fidavano di Joseph. La sofferenza e l’ansia gli si riversarono nelle orecchie svanite come acqua sulla sabbia del deserto e i penitenti lasciavano la loro presenza svuotata e calmata. D’altra parte, Dion, il guaritore più anziano, affrontava attivamente coloro che cercavano il suo aiuto. Individuava i loro peccati non confessati. Era un grande giudice, castigatore, rimproverava e raddrizzava, e guariva attraverso un intervento attivo. Trattando i penitenti come bambini, dava consigli, puniva assegnando penitenze, ordinava pellegrinaggi e matrimoni e costringeva i nemici a fare pace.
I due guaritori non si incontrarono mai e lavorarono come rivali per molti anni finché Joseph non si ammalò spiritualmente, cadde in una cupa disperazione e fu assalito da idee di autodistruzione. Incapace di curarsi con i propri metodi terapeutici, partì per un viaggio nel sud per chiedere aiuto a Dion.
L’incontro dei due guaritori
Durante il suo pellegrinaggio, Joseph si riposò una sera in un’oasi, dove tenne una conversazione con un viaggiatore più anziano. Quando Joseph descrisse lo scopo e la destinazione del suo pellegrinaggio, il viaggiatore si offrì come guida per assistere nella ricerca di Dion. Più tardi, nel bel mezzo del loro lungo viaggio insieme, il vecchio viaggiatore rivelò a Giuseppe la sua identità. Mirabile dictu: lui stesso era Dion, proprio l’uomo che Joseph cercava.
Senza esitazione Dion invitò il suo rivale più giovane e disperato nella sua casa, dove vissero e lavorarono insieme per molti anni. Dion chiese a Joseph di fare il servo. Più tardi lo elevò a studente e, infine, a collega a pieno titolo. Anni dopo, Dion si ammalò e sul letto di morte chiamò il suo giovane collega per ascoltare una confessione. Parlò della precedente terribile malattia di Joseph e del suo viaggio verso il vecchio Dion per chiedere aiuto. Parlò di come Joseph avesse sentito che era un miracolo che il suo compagno di viaggio e guida si fosse rivelato essere lo stesso Dion.
Ora che stava morendo, era giunta l’ora, disse Dion a Joseph, di rompere il suo silenzio su quel miracolo. Dion confessò che in quel momento era sembrato un miracolo anche a lui, perché anche lui era caduto nella disperazione. Anche lui si sentiva vuoto e spiritualmente morto e, incapace di aiutare se stesso, si era messo in viaggio per cercare aiuto. La notte stessa in cui si erano incontrati nell’oasi, era in pellegrinaggio per cercare un famoso guaritore di nome Joseph.
Joseph, Dion e la terapia
Il racconto di Hesse mi ha sempre commosso in modo preternaturale. Mi colpisce come un’affermazione profondamente illuminante sul dare e ricevere aiuto, sull’onestà e la doppiezza, e sul rapporto tra guaritore e paziente. I due uomini hanno ricevuto un aiuto potente ma in modi molto diversi. Il guaritore più giovane è stato nutrito, allattato, istruito, da un mentore e genitore. Il guaritore più anziano, invece, è stato aiutato a servire un altro, ottenendo un discepolo da cui ha ricevuto amore filiale, rispetto e balsamo per il suo isolamento.
Ma ora, ripensando alla storia, mi chiedo se questi due guaritori feriti non avrebbero potuto essere ancora più utili l’uno all’altro. Forse si sono lasciati sfuggire l’opportunità di qualcosa di più profondo, più autentico, più fortemente mutativo. Forse la vera terapia è avvenuta sulla scena del letto di morte, quando si sono mossi verso l’onestà con la rivelazione che erano compagni di viaggio, entrambi semplicemente umani, fin troppo umani. I vent’anni di segretezza, per quanto utili, possono aver ostacolato e impedito un aiuto più profondo, una terapia completa. Cosa sarebbe potuto succedere se la confessione sul letto di morte di Dion fosse avvenuta vent’anni prima, se guaritore e cercatore si fossero uniti per affrontare le domande che non hanno risposta?
Tutto questo fa eco alle lettere di Rilke a un giovane poeta in cui consiglia: “Abbiate pazienza con tutto ciò che non è stato risolto e cercate di amare le domande stesse”. Aggiungerei: “Cerca di amare anche chi pone le domande”.
Articolo liberamente tradotto e adattato. Fonte: Psychotherapy.net

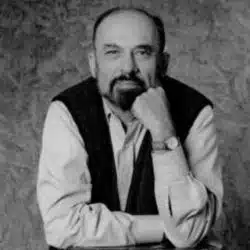






0 thoughts on “Il dono della terapia, di Irvin Yalom”
Isabella Vecchi says:
Condivido completamente.
Prendere le distanze dalla diagnosi per accogliere l'”Altro/a” nella sua unicità e complessità. Per poter intraprendere un cammino insieme, con lo scopo di offrire prospettive diverse di vedere i propri ostacoli (e rimuoverli) e per prendere ciò che quella specifica terapia è in grado di dare all’Altro, all’Altra e a noi stessi.
Marialisa D'Urso says:
Dopo aver letto questo articolo…sono corsa a comprare il libro :-)
Anna Lina OLIVIERI says:
Condivido il parere che nei casi non gravi la diagnosi immediata possa essere addirittura fuorviante.
Se devo ‘prendermi cura di’ non posso incontrare un sintomo ma una persona.
E la persona la si conosce poco per volta anzi la si accompagna a conoscersi essa stessa.
E questo mi sembra anche lo spirito del commento finale e del bellissimo racconto di Hesse che non conoscevo.
Buona giornata.