Personalità e funzionamenti complessi: una lettura attraverso le Terapie Brevi
Flavio Cannistrà & Valeria Campinoti
Introduzione
Il costrutto di “personalità” assume rilevanza clinica quando il modo abituale di percepire, pensare e agire limita in maniera pervasiva la flessibilità cognitiva, emotiva e relazionale. In questi casi, il funzionamento quotidiano risulta compromesso.
Finora queste difficoltà sono state incasellate in etichette diagnostiche, come quelle del DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022). Oggi, però, la prospettiva sta cambiando: conta sempre meno come chiamiamo il disturbo e sempre più quanto incide sulla vita di tutti i giorni. Lo conferma anche l’ICD-11, che parla di un’unica categoria di Disturbo di personalità e ne misura la gravità in base all’impatto sulla persona e le sue relazioni (World Health Organization [WHO], 2022).
In un’ottica simile, le Terapie Brevi offrono una prospettiva funzionale, centrata sui meccanismi che mantengono il problema e sulla rapidità del miglioramento. In tal senso, il focus si sposta dalla classificazione al cambiamento, dall’etichetta diagnostica all’osservazione del mantenimento del problema nel presente. L’ottica è quella di considerare il cambiamento come “possibile e a breve termine”, anche nei casi percepiti come “resistenti” o “cronici”.
In questo articolo forniremo una panoramica introduttiva su alcuni elementi peculiari relativi al concetto di personalità e al trattamento dei suoi “disturbi” secondo la visione delle Terapie Brevi.
- La difficoltà di definire la personalità
La definizione di personalità costituisce un nodo teorico tutt’altro che risolto. Come sottolineano Caprara e Gennaro (1999), la molteplicità delle concezioni esistenti riflette la varietà dei modelli psicologici disponibili, nonché le implicazioni epistemologiche e ideologiche che ciascun approccio porta con sé.
Con “personalità” si può intendere tanto un insieme di tratti condivisi tra individui, quanto la configurazione unica e irriducibile di una singola persona (Caprara & Gennaro, 1999, pp. 112–113). Questa duplice natura rende difficile tracciare confini netti rispetto a tale campo di studio.
Ad esempio, con “personalità” non ci si limita a descrivere l’insieme di caratteristiche stabili. Tale costrutto include le modalità con cui l’individuo percepisce e interagisce con il mondo.
Salvini (1998) ha posto l’accento su questo aspetto, ricordando che la personalità non può essere trattata alla stregua di un oggetto fisico, bensì come una costruzione teorica utile a spiegare il funzionamento psicologico e i comportamenti che ne derivano. A mostrare la complessità del quadro vi è l’influenza di quelli che l’autore chiama schemi di tipizzazione della personalità (STP), che rivelano l’insieme di categorie cognitive, credenze, norme contestuali e auto-attribuzioni attraverso cui l’osservatore interpreta e classifica il comportamento proprio e altrui (Salvini, 1998, pp. 69–70).
In sintesi, qualsiasi valutazione del costrutto di personalità è inevitabilmente influenzata da fattori soggettivi e culturali, rendendo il processo diagnostico meno neutro di quanto possa apparire. La domanda diventa dunque: come va considerato il suo funzionamento e, di conseguenza, il suo trattamento?
- Disturbi di personalità o funzionamenti complessi?
La classificazione dei disturbi di personalità, cioè delle variazioni di tale osservazione normativa, ha avuto un ruolo centrale nella psicopatologia contemporanea. Tuttavia, negli ultimi anni numerosi studi hanno messo in discussione l’utilità clinica delle categorie nosografiche rigide, evidenziandone i limiti in termini di efficacia terapeutica e comprensione del funzionamento individuale (Hopwood et al., 2018; Morey et al., 2021).
Le Terapie Brevi, pur riconoscendo l’importanza di tali costrutti, si distaccano da un’ottica categoriale e adottano una prospettiva operativa (Nardone et al., 2017). Significa comprendere il modo in cui la sofferenza viene attivamente mantenuta nel presente e i modi in cui produrre un cambiamento funzionale. In questa cornice, anche quadri clinici con caratteristiche riconducibili ai cosiddetti disturbi di personalità possono essere trattati efficacemente, senza la necessità di processi diagnostici complessi o percorsi orientati all’approfondimento delle cause passate (Fisch e Schlanger, 1998).
A volte la diagnosi, nei termini di una concettualizzazione del problema, può perfino essere del tutto assente (Simon e Nelson, 2007). Non si tratta di una posizione a priori: ciò che conta, in una declinazione operativa, è condurre un processo di indagine attraverso cui, per mezzo (dia-) della conoscenza (-gnosis), il fine non è la conoscenza stessa, ma il cambiamento (Hoyt e Cannistrà, 2023).
Questo è il motivo per cui piuttosto che parlare di “disturbi di personalità” si possano preferire delle alternative, come la più ampia ma al contempo più aperta definizione di “casi complessi”. Ciò su cui si orienta l’attenzione non è il malfunzionamento (disturbo) di un costrutto teorico (la personalità) che, parafrasando de Shazer (1995, p. 105), fa riferimento a una norma statistica da cui tutte le persone reali deviano. Piuttosto, ancora una volta, ci si concentra su cosa accade ora che si desidera cambiare, o su ciò che accadrà poi che si desidera raggiungere.
- Le Terapie Brevi nei casi complessi: principi e strategie operative
Una crescente letteratura evidenzia come un approccio focalizzato, breve e orientato a individuare e potenziare le risorse della persona può produrre cambiamenti significativi anche in pazienti con storie complesse, cronicità pregressa e scarsa fiducia nei confronti della possibilità di cambiamento (Cannistrà e Piccirilli, 2021, 2018; Nardone et al., 2017; Hoyt e Talmon, 2014; Simon e Nelson, 2007; Rowan e O’Hanlon, 2003; Berg e Miller, 1992).
Contrariamente all’idea secondo cui la durata del trattamento debba essere proporzionale alla gravità del problema, numerosi studi hanno dimostrato che anche situazioni cliniche articolate possono beneficiare di interventi brevi, purché ben strutturati e orientati al cambiamento (Vermeulen-Oskam et al., 2024).
Dalla letteratura è possibile ricavare alcuni punti chiave generali, che possono dare una prima idea di come le Terapie Brevi approcciano al lavoro con clienti con problematiche complesse, ascritte nell’area dei disturbi di personalità da un vocabolario nosografico.
3.1. Analisi del funzionamento attuale
Benché una valutazione più comprensiva non sia esclusa, soprattutto a fini di gestione della situazione, un approccio breve parte considerando che un sistema è definito sufficientemente bene dal proprio funzionamento attuale (Watzlawick et al., 1967). Da qui, l’attenzione del terapeuta si concentrerà prevalentemente su due aspetti: da un lato, analizzare le modalità con cui il disagio si manifesta e viene mantenuto, inclusi quei comportamenti e percezioni della persona che mantengono in vita il problema (tentate soluzioni disfunzionali – Nardone e Watzlawick, 1990); dall’altro, usare il dialogo per far emergere quelle situazioni in cui la persona è o è stata capace di influenzare positivamente il problema (eccezioni positive – Cannistrà e Piccirilli, 2021).
Il peso dato a queste due modalità di intervento varia da persona a persona, in parte da problema a problema, e sicuramente anche a seconda dello stile personale del terapeuta. In ogni caso, che si adotti un modello più centrato sul problem-solving (Nardone et al., 2017) o uno più rivolto al solution-building (Simon e Nelson, 2007; Rowan e O’Hanlon, 2003), l’idea sarà quella di comprendere come il sistema funziona oggi e quali sono le risorse disponibili della persona e le interazioni disfunzionali da bloccare.
Nell’ottica delle Terapie Brevi la complessità del caso non necessita una teorizzazione ugualmente complessa del funzionamento del problema o della persona. Ad esempio, Fisch e Schlanger (2002) ritengono che, come con qualunque altro problema trattato in una terapia strategica, il terapeuta sta sulle tentate soluzioni disfunzionali: la differenza è se ne riscontrerà una costellazione più ampia e/o con interazioni molteplici (gli autori parlano infatti di “casi multi-problematici”). Anche nella terapia solution-focused le linee guida del modello rimangono sostanzialmente identiche: piuttosto, si farà più attenzione a dinamiche comunicative, interazionali e relazionali tra terapeuta e cliente (Simon e Nelson, 2007; Rowan e O’Hanlon, 2003).
3.2. Obiettivi concreti e negoziati
Nel definire il funzionamento attuale, un approccio centrato sul presente prevede anche degli obiettivi da definire in modo chiaro. Come riferito da Berg e Miller (1992): “Senza obiettivi espliciti, è difficile per il cliente valutare i propri successi” (p. 32), al punto che, come dice de Shazer (1988): “senza questo passaggio la terapia potrebbe ragionevolmente continuare all’infinito” (p. 93).
Gli obiettivi terapeutici vengono quindi definiti in modo specifico, osservabile e condiviso con la persona. Questo consente di orientare l’intervento in modo pragmatico e misurabile, aumentando il senso di efficacia e coinvolgimento del paziente. Potrebbero essere più orientati alla scomparsa di un sintomo o problema specifico, o più legati al raggiungimento di uno “stile di vita” (Iveson et al., 2012).
Specialmente con casi complessi sarà probabile che questi vengano ridefiniti nel corso del trattamento: a volte per l’alternarsi di diversi sintomi o problemi; altre per il sopraggiungere di differenti sfide da gestire; altre ancora per un processo di scoperta e aggiustamento della direzione verso cui volgere. Ad esempio, Budman e Gurman (1988) suggeriscono di affrontare inizialmente gli aspetti sintomatologici e successivamente, se necessario, i pattern interazionali e comportamentali ridondanti disfunzionali. Nardone et al. (2017) identificano similmente tre fasi di intervento: una più centrata sul sintomo, una sul consolidamento, generalizzazione e consapevolezza dei risultati, e una sull’eventuale acquisizione/miglioramento di tappe evolutive deficitarie.
3.3. Interventi a impatto rapido e gestione della complessità
Le Terapie Brevi si distinguono per l’uso mirato e flessibile delle tecniche: ristrutturazioni narrative, compiti e/o esperienze tra le sedute, protocolli orientati alla soluzione e, quando indicato, interventi singoli ad alto impatto (Cannistrà & Hoyt, 2025; Cannistrà & Piccirilli, 2018; Slive & Bobele, 2011).
Come detto, una terapia problem oriented potrebbe concentrarsi innanzitutto sugli aspetti che mantengono in vita il problema più emergente o sintomatico (Fisch e Schlanger, 1998). Successivamente, e a volte parallelamente, il terapeuta potrà adottare una prospettiva sistemica. Lo scopo sarà di ricalibrare quegli elementi che permettono alla persona di mantenere e raggiungere un sano equilibrio e sano adattamento evolutivo (Nardone et al., 2017).
Anche strumenti propri delle terapie centrate sulle soluzioni possono essere utilizzati con efficacia: ne sono esempi la costruzione di eccezioni e l’amplificazione di piccole differenze (Cannistrà e Piccirilli, 2021). Ad esempio, Rowan e O’Hanlon (2003) suggeriscono di pensare in termini di fluttuazioni di stato: gli interventi saranno tesi ad aumentare la possibilità di accedere e mantenere lo stato desiderato. In tal modo non penseremo alle persone come “psicotici”, rischiando di reificare e generalizzare uno stato. Piuttosto, osserveremo che ogni persona in uno “stato psicotico” ha dei momenti o periodi in cui vive in uno “stato funzionale” o “desiderato”. L’intervento la aiuterà a identificarli, a spostare prevalentemente su di essi l’attenzione, a perpetuare ciò che aiuta a mantenerli, o a ripristinarli quando necessario.
Come detto, al terapeuta breve è chiara l’interdipendenza tra gli elementi dei diversi sistemi: per questo, spesso lavora direttamente con e su essi, primo tra tutti la famiglia. Ad esempio, Haley (1997) propone una modalità di intervento in cui il figlio (più spesso adolescente, giovane adulto o adulto non svincolato) viene visto assieme alla famiglia. Scopo essenziale sarà quello di “correggere la gerarchia nella famiglia in modo tale che i genitori siano al comando […] con un enfasi sui diritti [del figlio] in termini di decisioni e privacy” (p. 79). Il terapeuta aiuterà quindi la famiglia a stabilire regole chiare e a mantenerle, partendo dai genitori. Successivamente, lavorerà anche sulle dinamiche conflittuali della coppia e della famiglia, che spesso contribuiscono all’espressione e al mantenimento questi problemi.
In tale prospettiva, il terapeuta breve adotterà consapevolmente diversi stili relazionali (Nardone et al., 2017) concettualizzazioni della relazione in corso tra lui e il cliente (Hoyt e Miller, 2000; Berg, 1989). Ciò gli permetterà anche di aggiustare aspetti del setting come la frequenza o le persone presenti.
- Valutazione continua dei risultati
Un elemento centrale del dibattito psicoterapeutico moderno è la valutazione sistematica dell’andamento terapeutico (Reese, Duncan e Clements-Hickman, 2024). Il monitoraggio seduta dopo seduta consente di misurare l’efficacia dell’intervento e di rafforzare l’alleanza terapeutica, così da orientare le decisioni in modo flessibile e condiviso. Diversi studi longitudinali (Lambert, 2010; Barkham et al., 2021) hanno dimostrato che i pazienti che forniscono riscontri regolari sul proprio stato tendono ad avere esiti migliori rispetto a chi non lo fa. Ne consegue una significativa riduzione dei drop-out e un aumento del coinvolgimento nel trattamento. Questa evidenza acquista ancora più valore di fronte a casi la cui complessità richiede un’attenzione maggiore agli aspetti relazionali e una costante calibratura delle interazioni in seduta.
Accanto all’uso di protocolli formalizzati (Miller et al., 2020), le Terapie Brevi promuovono una cultura della valutazione continua. Ne è un esempio la pratica del chiedere costanti feedback nel corso di ogni singola seduta (Cannistrà e Piccirilli, 2021). Ciò permette al terapeuta di assumere una posizione riflessiva e responsiva, evitando il rischio di automatismi o percorsi terapeutici standardizzati. Inoltre, tale valutazione non ha solo una funzione tecnica, ma ha anche una consapevole valenza trasformativa. La restituzione diventa un’ulteriore manovra che permette di amplificare le risorse al servizio del cambiamento e modificare comportamenti e percezioni disfunzionali.
In sintesi, la valutazione continua non è un elemento accessorio, ma parte integrante della logica delle Terapie Brevi: ciò che non funziona si modifica, ciò che funziona si rafforza, sempre in un processo circolare tra osservazione, azione e ridefinizione condivisa degli obiettivi.
Conclusioni
Le evidenze che abbiamo oggi a disposizione indicano che Terapie Brevi rappresentano un’opzione clinica solida, scientificamente fondata e capace di intervenire efficacemente anche nei casi più complessi. Sebbene abbiano limiti e sfide da superare, cercano di oltrepassare la rigidità dei modelli categoriali tradizionali offrendo una lettura funzionale del comportamento e intervenendo in modo strategico sui meccanismi che mantengono la sofferenza, il disagio, il disturbo.
In questa prospettiva, la personalità non è un limite al cambiamento, ma un sistema aperto che può essere osservato, compreso e modificato attraverso esperienze terapeutiche mirate. Anche nei casi in cui il funzionamento appare radicato e resistente, è possibile costruire percorsi brevi ma trasformativi, in grado di restituire alla persona flessibilità, efficacia e nuove possibilità di interazione con sé e con gli altri.
Riferimenti bibliografici
American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed., Text Revision).
Berg, I. K. (1989). Of visitors, complainants, and customers: Is there really such a thing as “resistance?”. Family Therapy Networker, 13(1):21.
Berg, I. K., & Miller, S. (1992). Working with the Problem Drinker: a solution focused approach. Norton.
Budman, S. H., & Gurman, A. S. (1988). Theory and Practice of Brief Therapy. Guilford Press.
Cannistrà, F. & Hoyt, M. F. (Eds.) (2025). Single Session Therapies. Why and How One-at-a-time Mindsets are Effective. Routledge.
Cannistrà, F., & Piccirilli, F. (2018). Terapia a Seduta Singola. Principi e pratiche. Giunti Editore.
Cannistrà, F., & Piccirilli, F. (2021). Terapia Breve Centrata sulla Soluzione. Principi e pratiche. EPC.
Caprara, G. V., & Gennaro, A. (1999). La personalità: Teorie e modelli. Giunti.
de Shazer, S. (1988). Clues: Investigating Solutions in Brief Therapy. Norton.
de Shazer, S. (1995). Words were originally magic. Norton.
Fisch, R., & Schlanger, K. (1998). Brief Therapy with Intimidating Cases: Changing the Unchangeable. Jossey-Bass (Tr. it. Cambiare l’immutabile. Raffaello Cortina, 2002).
Haley, J. (1997). Leaving Home. 2nd ed. Taylor & Francis.
Hopwood, C. J., Wright, A. G. C., & Krueger, R. F. (2018). DSM-5 and the assessment of personality pathology. Annual Review of Clinical Psychology, 14, 417–440.
Hoyt, M. F. & Cannistrà, F. (2023). Conversazioni di terapia breve. EPC.
Hoyt, M. F., & Miller, S. D. (2000). Stage-appropriate change-oriented brief therapy strategies. In J. Carlson & L. Sperry (Eds.), Brief therapy with individuals & couples (pp. 289–330). Zeig, Tucker & Theisen.
Hoyt, M. F., & Talmon, M. (2014). Capturing the moment: Single session therapy and walk-in services. Crown House.
Iveson, C., George, E., & Ratner, H. (2012). Brief Coaching. A Solution Focused Approach. Routledge.
Lambert, M. J. (2010). Prevention of treatment failure: The use of measuring, monitoring, and feedback in clinical practice. American Psychological Association.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2008). The five-factor theory of personality. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research (3rd ed., pp. 159–181). Guilford Press.
Miller, S. D., Hubble, M. A., & Chow, D. L. (2020). Better results: Using deliberate practice to improve therapeutic effectiveness. APA Books.
Morey, L. C., Skodol, A. E., & Oldham, J. M. (2021). Twenty years of evidence on the prevalence and course of personality disorders. Current Opinion in Psychiatry, 34(1), 22–26.
Nardone, G., Balbi, E., Vallarino, A., & Bartoletti, M. (2017). Psicoterapia breve a lungo termine. Trattare con successo anche le psicopatologie maggiori. Ponte alle Grazie.
Nardone, G., & Watzlawick, P. (2005). L’arte del cambiamento. Ponte alle Grazie.
Rowan, T., & O’Hanlon, B. (2003). Solution Oriented Therapy for Chronic and Severe Mental Illness. 2nd ed. Norton.
Reese, R. J., Duncan, B. L., & Clements-Hickman, A. L. (2024). Do practice-generated data improve psychotherapy effectiveness (routine outcome monitoring)? In F. T. L. Leong, J. L. Callahan, J. Zimmerman, M. J. Constantino, & C. F. Eubanks (Eds.), APA handbook of psychotherapy: Evidence-based practice, practice-based evidence, and contextual participant-driven practice (pp. 193–211). American Psychological Association
Salvini, A. (1998). Manuale di psicologia della personalità. Carocci.
Simon, J. K., & Nelson, T. S. (2007). Solution-Focused Brief Practice with Long-Term Clients in Mental Health Services. Routledge.
Slive, A., & Bobele, M. (Eds.). (2011). When One Hour is All You Have: Effective Therapy for Walk-In Clients. Crown House.
Vermeulen-Oskam, E., Franklin, C., Van’t Hof, L. P. M., Stams, G. J. J. M., van Vugt, E. S., Assink, M., Veltman, E. J., Froerer, A. S., Staaks, J. P. C., & Zhang, A. (2024). The current evidence of solution-focused brief therapy: A meta-analysis of psychosocial outcomes and moderating factors. Clinical psychology review, 114, 102512.
Watzlawick, P., Bavelas, J.B. and Jackson, D.D. (1967) Pragmatics of Human Communication, A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. WW Norton & Company (tr. it. Pragmatica della comunicazione umana. Astrolabio-Ubaldini, 1971).
Watzlawick, P., Weakland, J. H., & Fisch, R. (1974). Change: Principles of problem formation and problem resolution. W. W. Norton (tr. it. Change. Sulla formazione e soluzione dei problemi. Astrolabio, 1974).
World Health Organization (WHO). (2024). Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders (CDDR). Sito: https://www.who.int/publications/i/item/9789240077263
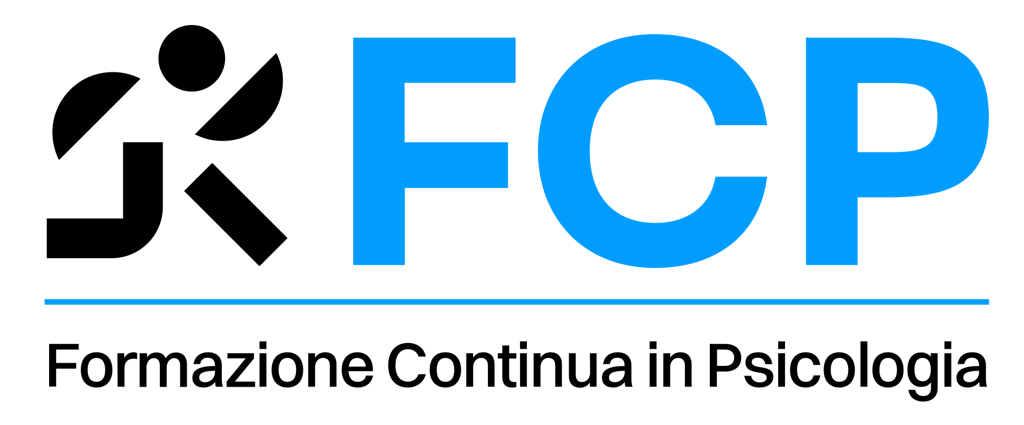


One thought on “Personalità e funzionamenti complessi: una lettura attraverso le Terapie Brevi”
aspromontelaura says:
molto interessante e grazie anche per l’ampia bibliografia