La psicologia umanistica
La psicologia umanistica affonda le proprie radici nella corrente filosofica definita “fenomenologico- esistenziale”.
All’inizio degli anni Sessanta, all’interno di una nuova prospettiva di pensiero che mirava a riportare al centro dell’indagine psicologica la soggettività e il vissuto della persona, nasce negli Stati Uniti quella che viene definita Psicologia Umanistica o “Psicologia della Terza Forza”, sostenuta da un gruppo di psicologi tra cui Carl Rogers, Rollo May e Abraham Maslow.
La Psicologia Umanistica ha ampliato il campo di osservazione dell’essere umano introducendo nuovi aspetti:
- l’attenzione alla persona e all’esperienza;
- l’interesse per temi come la libertà di scelta, la spinta creativa e l’autorealizzazione;
- la valorizzazione della persona e delle sue potenzialità;
- un significativo cambiamento nella concezione di malattia e salute.
IL TERAPEUTA UMANISTA
Il metodo della Psicoterapia Umanistica è olistico e dinamico, considera la persona come “unità bio- psico-sociale” e l’obiettivo è la comprensione del soggetto nella sua totalità individuale. Alcuni aspetti centrali di questo approccio sono proprio la visione della funzionalità e della potenzialità dell’essere umano, che creano quindi la possibilità di uscire da una visione patologizzante dell’individuo.
Nella terapia umanistica l’attenzione è al “qui ed ora”, al processo attuale di ciò che avviene dentro la stanza e soprattutto alle emozioni manifestate o più spesso nascoste dalla persona. Le emozioni assumono un ruolo fondamentale all’interno dell’approccio, diventando sia bersagli che agenti di cambiamento. Il terapeuta entra in contatto con l’emozione della persona, validandola e restituendola con empatia, sintonizzandosi ad essa ed esplorandola con accettazione positiva incondizionata e completa assenza di giudizio. La funzione del terapeuta è proprio quella di creare un’atmosfera di empatia e di accettazione comprensiva (definita da Rogers “considerazione positiva incondizionata”, 1951), al fine di creare un’alleanza terapeutica sicura e collaborativa.
UN TERAPEUTA “CALDO”
Una relazione sicura, in cui il paziente possa sentirsi accettato e validato nei suoi vissuti, non può non tener conto delle emozioni del terapeuta stesso, di ciò che sente e vive dentro di sé mentre il paziente parla. Ma queste emozioni si possono esprimere? Se sì, che effetto avranno sul paziente? Secondo Nancy McWilliams, psicologa e psicanalista, “il lettino permette al terapeuta la libertà di rispondere internamente al materiale del paziente senza autocoscienza: fantasticare, rispondere affettivamente, persino piangere senza preoccuparsi che il paziente sia distratto dai processi interni dalla reattività emotiva del terapeuta” (McWilliams, 1994).
Non sono molti gli studi che approfondiscono tale argomento, come il pianto del terapeuta di fronte al paziente (therapists’ crying in therapy). Secondo uno studio il 72% dei 684 psicologi intervistati ha riportato di aver pianto in terapia (Blume-Marcovici et al., 2013). In un altro studio è emerso come il 66% dei clinici che sono stati intervistati e che non hanno discusso del pianto con il paziente abbia riportato un miglioramento nella relazione (Blume-Marcovici et al., 2015).
Altri studi mostrano che quando le lacrime sono percepite come segno di empatia, fiducia, affidabilità possono mostrare effetti positivi sulla terapia e sull’alleanza; se invece le lacrime sono percepite dal paziente come un segno di scarsa competenza e professionalità, possono emergere effetti negativi sulla relazione (‘t Lam et al., 2018). Ciò che ritengo estremamente importante in questo senso è proprio la possibilità di utilizzare tale pianto
(come ogni altra emozione) come strumento di terapia, come veicolo per facilitare nel paziente l’occasione di viversi liberamente e pienamente le proprie emozioni. “Come ti fanno sentire queste mie lacrime?”; “Mentre tu parli mi arriva forte la tua emozione: quante volte ti concedi di poterti emozionare di fronte ad altre persone?” Queste tipicamente sono le domande che più spesso pongo ai miei pazienti. Continuamente mi focalizzo su questo aspetto: il terapeuta è il principale strumento e la primaria tecnica da utilizzare in terapia. Un terapeuta caldo, empatico, in grado di connettersi emotivamente alla persona e sintonizzarsi su ciò che sta vivendo è lo strumento più potente per poter sciogliere nel paziente quel blocco emotivo, per poter facilitare la sua possibilità di viversi pienamente le emozioni e di poterle utilizzare in modo funzionale nella sua vita, nel suo lavoro, nelle sue relazioni.
CARL ROGERS
L’impostazione rogersiana è considerata un po’ il simbolo di tutta la psicoterapia umanistica: secondo tale prospettiva il rapporto terapeutico va considerato come il rapporto tra due persone, in cui il terapeuta porta non solo la propria competenza professionale, ma anche la sua sensibilità, la sua esperienza, la sua disponibilità all’ascolto ed all’aiuto.
L’individuo non è più ridotto ai suoi sintomi o a ciò che non va, ma è una totalità, dove ogni sua espressione, sia fisica che mentale, rappresenta solo una parte del suo significato, delle sue emozioni e della sua espressione di vita.
Reich sperimentò come rilassare i muscoli cronicamente tesi mediante la pressione diretta su di loro. In questo modo il paziente poteva entrare in contatto con emozioni forti e a lungo dimenticate e con ricordi dolorosi. L’unità di mente, corpo ed emozioni divenne più chiara. Egli notò anche che, a questo punto, il paziente cominciava a sembrare più vivo, la sua pelle più rosea, i movimenti più spontanei, gli occhi più luminosi. Era come se avesse più energia. Reich chiamò questa energia ritrovata con l’appellativo di “organismica” o “orgone“.
Lowen ha il merito di aver intuito anche altro, forse ancora più importante: fintanto che abbiamo l’illusione di poter ottenere, da adulti, quello che ci è mancato da bambini, e che questo ci farà uscire dalla depressione, siamo predestinati a fallire. Nessun amore, nessuna accettazione da parte del terapeuta, o del compagno, ci potrà restituire l’esperienza perduta di essere accettati e amati per quello che eravamo da bambini. Poiché abbiamo permanentemente bloccato alcune inaccettabili autoespressioni non potremo mai fare l’esperienza di essere accettati per quello che siamo. Perché i nostri genitori ci hanno negato il sentirci accettati quando noi eravamo pieni di amore per loro? Questo ci procura una rabbia profonda ed inconscia. Ma è anche una rabbia giustificata.
Allentare questi blocchi non è mai facile. Noi crediamo che essi ci salvino dall’essere abbandonati e dalla terribile solitudine che ne conseguirebbe. Attraverso il lavoro con il corpo possiamo ammorbidire le tensioni e rivivere il desiderio di essere accettati e amati e la tremenda tristezza di aver desiderato invano. Essendo ben radicati ed avendo un corpo pieno di energia possiamo vivere nella nostra realtà adulta e perciò sentire che la ricerca tesa a recuperare quanto perduto da bambini è un’illusione. In terapia questo viene spesso percepito come una scelta fra essere sé stessi – liberi e soli – e tenersi stretti al terapeuta e al suo amore.
I CINQUE CARATTERI BIOENERGETICI
L’aspetto antitetico del processo vitale è riflesso efficacemente nella relazione tra mente e corpo. Rispettare questo dualismo permette di riconoscere che l’atteggiamento conscio di una persona ha un’influenza considerevole sul suo funzionamento complessivo. Ciò permette al terapeuta di introdurre dei valori in ogni discussione sul comportamento umano. Rendere disponibile al paziente più energia attraverso il lavoro bioenergetico con il corpo facilita quindi il processo di cambiamento.
Secondo la teoria dell’analisi bioenergetica, ci sono 5 tipi fondamentali di struttura del carattere. Questi tipi sono basati sull’organizzazione libidica e sullo sviluppo dell’Io così come essi si manifestano nel corpo. Sono:
- la struttura del carattere Schizoide: la struttura di carattere schizoide è connessa a una tendenza a scindere e a dissociare. Il pensiero è scisso dal sentimento. Ciò si manifesta a livello corporeo nella carenza di una buona connessione fra la testa e il tronco. In alcuni il collo è allungato, invece in altri la testa è inclinata rispetto alla linea del corpo. Questa dissociazione fra testa e corpo significa che una persona non si sente collegata al proprio corpo. In un caso grave, si può arrivare al fenomeno della depersonalizzazione. Nella personalità schizoide si rileva anche una scissione tra la metà superiore e inferiore del corpo, manifestata da una carenza di proporzione e armonia tra le due metà del corpo. La personalità è caratterizzata dalla paura di andare in pezzi se ci si abbandona, contrastata dal bisogno di tenere assieme il proprio Sé mediante la tensione di tutti i muscoli articolatori.
- la struttura del carattere Orale: la struttura di carattere orale sorge da una deprivazione di cura e sostegno nella prima infanzia e si associa alla paura di abbandono. Questa paura si manifesta soprattutto nella magrezza, nella mancanza di sostegno nelle gambe e nei piedi e in un ridotto sviluppo della muscolatura. Il carattere orale ha una forte propensione verso la dipendenza. Il carattere si tiene stretto al Sé mediante una forte tensione nel cingolo scapolare e nelle gambe per impedire la caduta, che simboleggerebbe l’essere lasciati soli e abbandonati.
- la struttura del carattere Masochista: la struttura di questo carattere si sviluppa in un bambino che è stato accudito, ma anche forzato ad essere sottomesso al genitore. Il masochista tiene dentro tutti i sentimenti mediante la tensione dei muscoli che controllano le uscite alle estremità superiore e inferiore del corpo. Gli atteggiamenti masochistici sono spesso associati a un controllo precoce degli sfinteri: il bisogno di trattenere dentro di sé e la paura di lasciare uscire. A livello corporeo, il masochista è pesante e con una muscolatura ipersviluppata, con la tensione principale nei muscoli flessori, cosa che porta a un collasso della postura eretta del corpo.
- la struttura del carattere Psicopatico: tra i due e i quattro anni di vita, in relazione al genitore di sesso opposto – molto seduttivo e ambivalente che rifiuta il contatto fisico e tradisce i reali sentimenti e bisogni del bambino che non viene visto come realmente è – si forma il carattere psicopatico. Così facendo, il genitore soddisfa i propri desideri narcisistici per legare il bambino a sé. Il corpo dell’adulto psicopatico di sesso maschile evidenzia una tensione nelle spalle, il petto in fuori con la parte superiore pesante, gonfia e più sviluppata di quella inferiore allo scopo di sostenere un’immagine di potenza. C’è una divisione, infatti, tra le parti superiore e inferiore tra le quali non c’è un passaggio di energia. La zona occipitale e gli occhi sono contratti, lo sguardo è seduttivo e indagatore, il bacino è scarico e possiede uno scarso radicamento. Nelle donne, invece, la struttura si presenta spesso “spiazzata verso il basso”, a pera, con una combinazione di oralità (nella parte superiore) e di masochismo (nella parte inferiore).
- la struttura del carattere Rigido: la struttura del carattere rigido, fallica-narcisistica nell’uomo e isterica nella donna, è caratterizzata da un corpo eretto e dritto con un considerevole orgoglio. Tuttavia, la postura eretta è mantenuta tramite una rigidità dei muscoli del dorso che denota un atteggiamento trattenuto. Questo trattenersi del carattere rigido sorge da una esperienza precoce di umiliazione da parte del genitore di sesso opposto all’epoca del periodo edipico, quando il bambino avvertiva interesse sessuale per quel genitore.
Molte persone presentano una mistura di più tendenze e appartengono a due o più tipi. Nessun individuo può essere completamente compromesso nei soli termini del tipo di carattere principale che lo definisce, perché questa è solo una cornice per l’osservazione clinica.
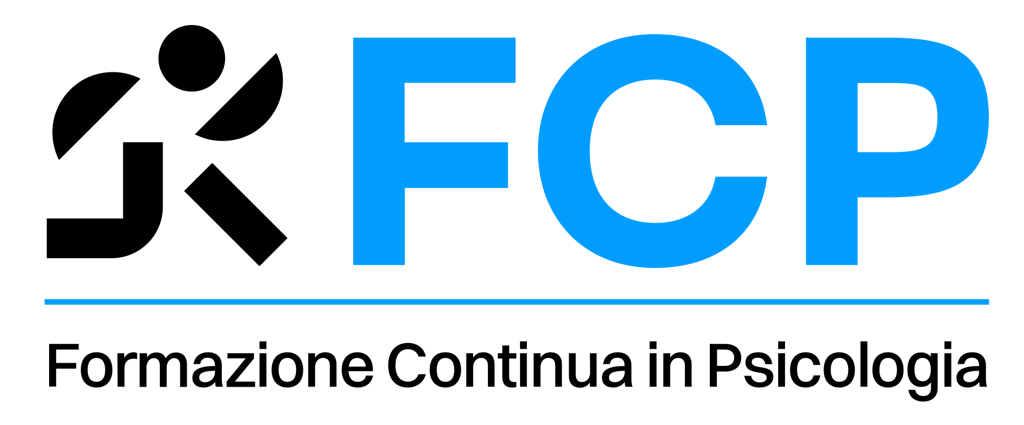
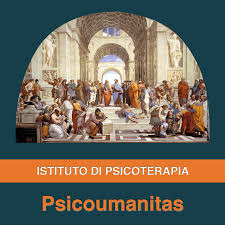




0 thoughts on “La psicologia umanistica”
aspromontelaura says:
scusate errore scrittura sopra
aspromontelaura says:
molto interessante rogers da rileggere di nuovo
aspromontelaura says:
Rileggerei volentieri Rogers