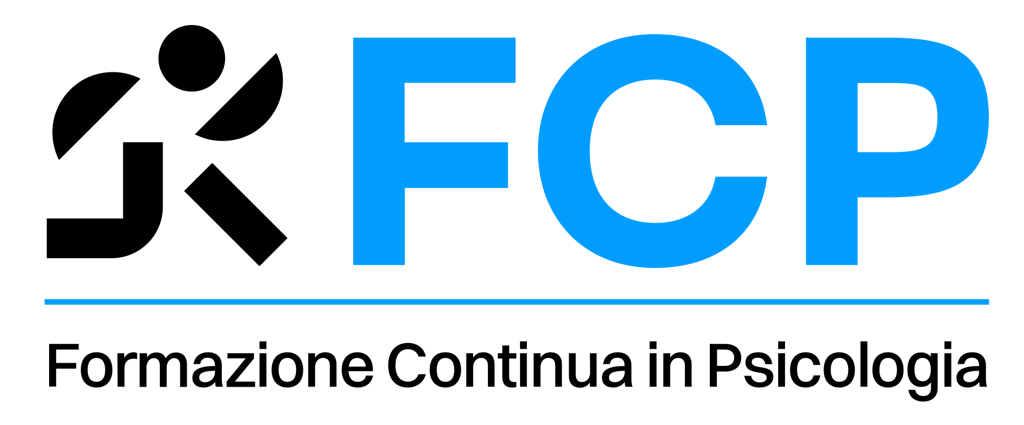Nonostante sia relativamente comune nella pratica clinica incontrare clienti con la presentazione di un certo grado di rischio di suicidio, spesso non siamo attrezzati, a causa delle nostre esperienze formative, per rispondere ad esso.
È un paradosso interessante che per molti che si formano nelle professioni di aiuto il tempo dedicato a come potrebbero rispondere più efficacemente ai loro clienti o pazienti a rischio di suicidio è sproporzionatamente basso rispetto al numero di clienti che probabilmente incontreranno e che presentano un certo grado di tendenza al suicidio.
Consapevolezza e gestione del rischio di suicidio
Qualche tempo fa, ho intrapreso uno studio tramite questionario esaminando come i tirocinanti dei corsi di formazione accreditati dalla British Association for Counseling and Psychotherapy (BACP) affrontavano le questioni di rischio nella loro formazione. Tra i numerosi risultati vi è quello che quasi il 10% dei leader del programma non ritiene che i propri laureati – consulenti e psicoterapeuti – siano adeguatamente preparati a lavorare con clienti con rischio di suicidio.
Nel corso degli anni, e come conseguenza del suicidio di uno dei miei clienti in terapia (di cui parlerò più avanti), ho scritto ampiamente sul lavoro con il suicidio e ho formato molte migliaia di professionisti della salute mentale su come lavorare con il potenziale suicidario.
Probabilmente è giusto dire che non mancano le sessioni di formazione sulla valutazione del rischio a cui partecipare ma, come esploreremo, pochissimi si concentrano sui meccanismi dialogici del lavoro efficace e guardano invece all’applicazione della “scienza” – gli strumenti di valutazione del rischio.
Esplorazione dialogica del rischio di suicidio
L’energia investita nella scienza della valutazione del rischio va, tipicamente, a scapito dell’esplorazione dialogica del rischio. Ciò non è tuttavia privo di sfide, poiché un approccio dialogico al lavoro con il rischio di suicidio richiede al professionista di essere veramente presente nella narrativa condivisa del suicidio, e deve essere pronto ad andare in luoghi difficili con il suo cliente e capire cosa sta succedendo.
Le sfide del lavoro con clienti a rischio di suicidio
Le sfide nel lavorare con clienti con tendenze suicide sono molteplici e possono, a un livello più elementare, essere suddivise in un quadro professionale e personale. Ciò, ovviamente, non rende piena giustizia alle complessità che si possono incontrare, a livello inter e intrapersonale, quando si lavora con il rischio di suicidio, ma una considerazione degli aspetti personali e professionali è un importante punto di partenza per la maggior parte dei professionisti.
È fondamentale che tali sfide siano delineate ed esplorate perché, come anticipato, un approccio dialogico al lavoro con il rischio richiede che il professionista abbia una certa comprensione delle proprie risposte professionali e personali, per supportare la potenziale intimità della narrazione.
Summit internazionale “SUICIDIO, AUTOLESIONISMO & TRAUMA. Strategie essenziali per la speranza, la guarigione e il recupero”
Sfide professionali per lavorare con clienti a rischio di suicidio
Ci sono una serie di fattori professionali che saranno presenti quando si lavora con un potenziale paziente suicidario; questi includono:
- gestire le aspettative di riservatezza;
- comprendere i diversi modi in cui il suicidio può presentarsi;
- paura di “sbagliare”;
- comunicare il rischio in un contesto multidisciplinare;
- un attento equilibrio tra regole, pratica, etica e valori.
1. Gestire le aspettative di riservatezza
La maggior parte dei professionisti lavorerà secondo una qualche forma di accordo di riservatezza, generalmente delineato in un contratto concordato con il cliente fin dall’inizio. Questo sarà il caso di coloro che lavorano in una vasta gamma di contesti, come ad esempio quelli legali (sanità e assistenza sociale), l’istruzione (scuole, università), gli ambienti del terzo settore e la pratica indipendente (privata), per esempio.
Sebbene il contratto prenda in considerazione una serie di fattori pratici, delinea anche il modo in cui si risponderà alla riservatezza, compreso quello del rischio per se stessi (potenziale suicidio o autolesionismo). Mentre alcuni professionisti indipendenti possono mantenere la riservatezza di fronte al rischio di suicidio, la maggior parte dei contesti organizzativi e la maggior parte dei professionisti indipendenti limiteranno la riservatezza qualora ritengano che il loro cliente presenti un rischio di suicidio immediato.
Sebbene molti professionisti stipulino regolarmente questi accordi, pochi ne considerano effettivamente le ramificazioni: come verrà misurata l’immediatezza del rischio. Molti clienti esploreranno l’idea suicidaria nelle relazioni d’aiuto (pensieri di suicidio, piuttosto che l’intenzione di agire in base a tali pensieri), ma ciò non costituirebbe un rischio immediato e molti professionisti manterrebbero la riservatezza del proprio cliente per consentire l’esplorazione di tali pensieri. Qui sta una verità espressa da Schneidman (1998) quando scrisse: “La maggior parte delle persone che si suicidano ne parlano; la maggior parte delle persone che parlano di suicidio non lo commettono. A cosa credere?” Esprimere giudizi sulle intenzioni di un altro, e in particolare sul fatto che sia concentrato o meno sul porre fine alla propria vita, può sembrare un giudizio davvero oneroso.
2. Comprendere i diversi modi in cui il suicidio può presentarsi
Mentre il suicidio può essere definito semplicemente come “l’atto di suicidarsi” (APA, 2000), il processo che porta al suicidio può essere altamente complesso e individuale. Esistono molte teorie che offrono una certa comprensione del movimento verso il suicidio (Schneidman, 1998; Joiner, 2005; O’Connor, 2011). La mia ricerca, basata su un’analisi critica del discorso (Reeves et al., 2006), ha identificato tre principali repertori interpretativi riguardo al suicidio:
- il suicidio pone fine alla crisi esistenziale
“Che senso ha, che senso ha andare avanti? Mi sento davvero solo con tutto questo… sento semplicemente che non esisto – non appartengo alla vita in cui vivo…”.
- il suicidio rimuove la sensazione di essere “bloccati” nella vita
“Sto pensando di darci un taglio. Non vedo cosa mi trattiene qui, o perché continuo ad andare avanti. Mi sento bloccato e non riesco a vedere una via d’uscita. Ho bisogno di uscire e andare da qualche altra parte – ho bisogno di uscire dalla gente e uscire da questa situazione di blocco”.
- il suicidio pone fine all’apatia e alla stanchezza
“Sono semplicemente troppo stanco per andare avanti. Mi sento così pesante che non so se potrò continuare a gestirlo ancora. Mi sento così stanco ed esausto nel continuare così. Non voglio che le persone si preoccupino più per me. Ho bisogno di portare via il dolore, di alleviare il dolore”.
Questi diversi fattori intrapersonali per il rischio di suicidio sono ulteriormente complicati dalla presentazione comportamentale. Cioè, il suicidio è spesso considerato come un lento movimento verso la morte, magari a seguito di un trauma o come conseguenza di una malattia fisica, con la persona che mette in ordine i propri affari, magari scrivendo note di suicidio e così via.
Anche se questo è certamente vero per molti, non coglie l’esperienza di altri, che può includere la convivenza quotidiana con pensieri suicidi, fino al non avere pensieri suicidi ma rispondere a una crisi con un atto impulsivo. Convivere quotidianamente con pensieri suicidi, un movimento verso il suicidio o un atto impulsivo presentano ciascuno sfide diverse per il professionista.
3. La paura di “sbagliare”
Considerare la gestione del contratto, nel contesto del modo complesso in cui il suicidio potrebbe presentarsi a livello intrapersonale, cognitivo, interpersonale e comportamentale, lascia comprensibilmente molti professionisti timorosi di “sbagliare” (Reeves e Mintz, 2001).
Tra le ricerche disponibili che esplorano le esigenze di lavorare con clienti a rischio di suicidio nelle relazioni di aiuto (di cui sorprendentemente c’è poco), la paura di sbagliare – di rompere inutilmente la riservatezza o di non agire al momento giusto, è stata evidenziata come un problema nel lavoro quotidiano. La paura è stata spesso descritta come immobilizzante, portando i professionisti a evitare discussioni sul suicidio, ove possibile, fino all’impatto di un trauma indiretto. Nella ricerca si nota che il lavoro in corso con un potenziale suicidario può avere un impatto, psicologico ed emotivo, sul professionista tanto quanto l’esperienza della morte di un cliente a causa del suicidio.
4. Comunicare il rischio in un contesto multidisciplinare
Anche se questo non è sempre il caso a tutti i livelli, molti professionisti lavorano all’interno di team multidisciplinari, dove gli interventi sono informati attraverso una serie di lenti teoriche e filosofiche diverse, e talvolta concorrenti o contraddittorie.
Trovare un linguaggio comune attraverso il quale l’esperienza del cliente possa essere compresa e, ove necessario, condivisa, può rappresentare un ostacolo significativo. Nel contesto del lavoro con il potenziale suicidario, sempre più il linguaggio condiviso è passato attraverso la “lettura” degli strumenti di valutazione del rischio e l’interpretazione di tali dati. Non viene dato sufficiente spazio all’interpretazione dialogica dell’esperienza di un cliente. Comunicare la preoccupazione agli altri, o anche sostenere il lavoro in corso a fronte del rischio percepito, può essere difficile quando i dati dicono il contrario.
5. Un attento equilibrio tra regole, pratica, etica e valori
Nel complesso, quindi, i professionisti si muovono attraverso un terreno difficile fatto di: aspettative regolamentari; parametri pratici; l’interpretazione e l’applicazione di vari “quadri etici” e orientamenti sulle buone pratiche; così come i propri valori. Non è raro che tali valori siano in contrasto con le aspettative regolamentari che, a loro volta, aumentano le sfide personali da considerare.
Sfide personali per lavorare con clienti a rischio di suicidio
Oltre ai fattori professionali, alcuni dei quali sono stati delineati sopra, ci sono quelli personali. Molti autori di consulenza e psicoterapia sostengono che il terapeuta dovrebbe lasciare tutto nella stanza di terapia. Mentre questa aspettativa potrebbe essere teoricamente più coerente con alcune scuole di terapia, ad esempio la psicoanalisi, in realtà si potrebbe invece sostenere che nessun professionista, indipendentemente dal suo orientamento teorico, può mai essere veramente obiettivo in una relazione di aiuto e, quindi, l’esperienza soggettiva sarà inevitabilmente presente.
In questo contesto, ci sono alcune sfide personali specifiche che il professionista dovrà affrontare:
- esperienze personali di crisi di salute mentale;
- opinioni personali in relazione al suicidio;
- il grado di dissonanza con le regole del contesto di lavoro;
- cura di sé e strategie di coping.
1. Esperienze personali di crisi di salute mentale
Mentre alcuni vorrebbero farci credere che ci sono persone che hanno problemi di salute mentale, e poi che ci sono il resto di noi che, presumibilmente, sono “normali”, questo è, ovviamente, un nonsenso. Allo stesso modo in cui tutti dobbiamo occuparci della nostra salute fisica, lo stesso vale per la nostra salute mentale. In questo contesto, quindi, l’esperienza personale dei professionisti riguardo alle difficoltà di salute mentale e il modo in cui sono stati in grado di affrontarle – attraverso il proprio supporto e/o l’aiuto di altri – giocherà un ruolo importante nel modellare il modo in cui rispondono al disagio mentale degli altri.
Nello specifico, anche in questo caso sarà importante la misura in cui il professionista è stato in grado di trovare una narrazione per la propria angoscia, sia per se stesso che da condividere con gli altri. In parole povere, se siamo stati in grado di dare un senso alla nostra angoscia attraverso il dialogo interiore o parlando con gli altri, è più probabile che saremo in grado di fornire quello spazio ai nostri clienti.
Il concetto di “guaritore ferito” (Larisey, 2012) è ben consolidato: coloro che trovano la loro strada verso ruoli professionali di aiuto lo fanno, almeno in parte, a causa delle loro “ferite” precedenti. Non è raro tuttavia, attingendo aneddoticamente a oltre 30 anni di pratica e al supporto di alcune prove di ricerca limitate (Adams, 2013), che i professionisti spesso abbiano difficoltà a farsi aiutare. Dal punto di vista relazionale, quindi, si potrebbe speculare sull’impatto di un professionista che fatica a verbalizzare la propria angoscia sulla capacità di supportare un altro.
2. Opinioni personali in relazione al suicidio
Il suicidio è uno di quegli argomenti che raramente viene visto attraverso una lente neutrale. Le persone possono spesso avere una risposta viscerale al suicidio, nello stesso modo in cui possono avere una risposta più generale alla morte. A questo si aggiunge lo stigma che ancora circonda la salute mentale – anche se di recente forse in misura minore – e certamente abbondano ancora gli echi storici della vergogna del suicidio quando veniva considerato “contro Dio”, o un atto illegale.
Pertanto, i professionisti non fanno tabula rasa quando si tratta di suicidio e le loro opinioni personali sul suicidio – che vanno dal credere che le persone abbiano il diritto di porre fine alla propria vita se hanno la capacità di prendere tale decisione, fino al fatto che la scelta del suicidio non sia mai accettabile – saranno presenti nella relazione di aiuto, esplicitamente o implicitamente. Tali opinioni saranno modellate da una serie di fattori, quali:
- fede;
- musica e letteratura;
- esperienze di suicidio tra familiari e amici;
- formazione.
La sfida è che il professionista sia disposto a impegnarsi in una riflessione interna in modo che le sue opinioni gli siano note e mantenute di conseguenza nella relazione di aiuto in modo che non plasmino consciamente o inconsciamente la natura dell’aiuto offerto.
La supervisione, di cui parleremo più dettagliatamente più avanti, è importante in questo caso per aiutare i professionisti a riflettere sulla propria relazione filosofica, pratica e teorica con il suicidio. Importanti qui sono le osservazioni di Shea (2011, p 4) secondo cui, “… quando un [professionista] inizia a comprendere i propri atteggiamenti, pregiudizi e risposte al suicidio, lui o lei può diventare più disponibile psicologicamente ed emotivamente verso un cliente a rischio di suicidio. I clienti sembrano essere in grado di percepire quando un [professionista] è a suo agio con l’argomento del suicidio. A quel punto, e con un tale [professionista], i clienti potrebbero sentirsi abbastanza sicuri da condividere l’immediatezza della loro spinta verso la morte“.
3. Il grado di dissonanza con le regole del contesto di lavoro
Alla luce delle esperienze personali di crisi di salute mentale e delle opinioni personali sul suicidio, non è raro che i professionisti si trovino a lavorare in contesti in cui le loro opinioni personali sono contraddittorie con quelle del contesto di lavoro.
Questo deve essere gestito professionalmente, con i professionisti che a volte devono agire in un modo incoerente con come potrebbero farlo personalmente. La mia ricerca tra i counselor ha suggerito, tuttavia, che quando c’era un conflitto tra la visione del suicidio di un counselor e quella del contesto all’interno del quale il lavoro veniva svolto, questi tendevano a favorire la propria visione, ignorando quella del contesto di lavoro (Reeves e Mintz, 2001). Ciò, ovviamente, solleva alcune difficili questioni professionali ed etiche.
4. Cura di sé e strategie di coping
È un requisito etico che i professionisti facciano esplicito riferimento al proprio benessere e alla cura di sé. Gli accordi formali di supervisione, ancora una volta un requisito degli organismi professionali per una serie di professioni diverse, svolgono un ruolo importante nel garantire le cure del professionista.
Al di là di tali accordi formali, tuttavia, è fondamentale che il professionista metta in atto le proprie strategie per la cura di sé. In caso contrario, spesso si verificano traumi indiretti, compassion fatigue e burnout (Marriage and Marriage, 2005; Moore e Donohue, 2016). I professionisti della salute mentale non sono immuni dai pericoli della dissociazione, in cui l’esperienza vissuta della relazione di aiuto si perde in un senso di attacco, rabbia e risentimento nei confronti dei clienti che sono percepiti come “troppo bisognosi” o “manipolatori”. In questo contesto, si perde la capacità di una narrazione empatica e significativa.

Rischio di suicidio: approfondimenti sulla ricerca
La letteratura sul lavoro con il suicidio è ampia, ma anche limitata. Estesa nella misura in cui la ricerca di una risposta definitiva alla domanda su chi ha maggiori probabilità di porre fine alla propria vita con il suicidio sembra condurre a una ricerca insaziabile e a studi infiniti. Nello scrivere questo capitolo ho intrapreso una breve ricerca bibliografica di articoli accademici relativi ai termini di ricerca “valutazione del rischio di suicidio”, dal 2019, e ho riscontrato circa 17.200 articoli.
Tra gli articoli analizzati, la maggioranza si è occupata di uno dei seguenti temi predominanti:
- l’ampia identificazione di specifici fattori di rischio;
- la fornitura di programmi di intervento sul suicidio;
- comprendere il suicidio nei diversi gruppi demografici e culturali;
- l’epidemiologia del suicidio
- modelli di pensiero suicidario e processo pre-suicidario;
- lo sviluppo, l’implementazione e la valutazione di strumenti per la valutazione del rischio di suicidio.
Cosa manca nella letteratura?
Lo spazio non consente un resoconto significativo della portata della letteratura. Piuttosto, e forse ancora più importante, è una considerazione di ciò che potrebbe mancare. In questo contesto è utile considerare la meta-analisi condotta da Large et al (2016), citata in Reeves (2019), che ha affermato: “il 95% dei pazienti ad alto rischio non muore per suicidio, e non si è verificato alcun aumento significativo nell’accuratezza della previsione del suicidio negli ultimi 40 anni”.
Reeves (2019, p 3) prosegue affermando che gli strumenti di valutazione del rischio di suicidio “possono contribuire a una comprensione [del rischio di suicidio] e possono permettere un’esplorazione più approfondita, ma il problema è che troppi li vedono come l’inizio e la fine del lavoro con il suicidio, piuttosto che semplicemente un punto di partenza. Riponiamo così tanta fiducia nella loro accuratezza predittiva che, troppo spesso, dimentichiamo di rivolgerci al cliente”.
L’Obiettivo Zero per il suicidio nel Regno Unito negli ambienti del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) (Vice Primo Ministro, 2015) si basa sul presupposto che si conosca sufficientemente chi e come del suicidio affinché tali obiettivi diventino non solo ambiziosi, ma piuttosto realizzabili. Considerando invece l’affermazione di Large e colleghi, il chi e il come continuano a essere concetti sfuggenti che creano false aspettative per politici, ricercatori, professionisti e, forse, anche per i clienti. Legato a questi enigmi epistemologici e ontologici rispetto al suicidio, è il luogo della comunicazione. Come affermato altrove in questo capitolo, troppo spesso ci affidiamo all’efficacia degli strumenti di valutazione del rischio per paura di andare in un luogo più spaventoso. Propongo qui una riflessione personale.
Riflessioni sulla scienza
Ho menzionato in precedenza la morte del mio cliente all’inizio della mia carriera e l’impatto traumatico che ha avuto su di me. Per impatto traumatico mi riferisco al trauma con la T maiuscola, invece che semplicemente angosciante. Sono diventato ipervigile rispetto ai potenziali rischi, ho sperimentato flashback, incubi, ecc. e mi sono allontanato dalla pratica per un po’ per consentire un periodo di recupero.
Intraprendendo i miei studi di dottorato in quest’area, la mia proposta di ricerca a un’affermata università del Regno Unito era lo sviluppo di uno strumento di valutazione del rischio per consulenti della salute mentale che, una volta completato, avrebbe definitivamente detto al professionista se il cliente si sarebbe ucciso.
È stato solo durante il corso del dottorato che questo progetto è decaduto: uno strumento del genere non esisteva, ma lo avevo voluto a causa del trauma seguito alla morte del mio cliente e, semplicemente, non volevo tornarci mai più. Avevo perso la capacità di lavorare con l’incertezza, che rimane la pietra angolare della pratica con clienti potenzialmente suicidari.
La svolta nella ricerca
Partendo da questa consapevolezza, la mia ricerca ha preso una svolta molto diversa – una svolta al discorso – e ha esaminato i modi in cui i professionisti potrebbero essere supportati, attraverso la formazione, ad affrontare anche l’incertezza, costruendo al contempo fiducia e capacità di parlare ai clienti del suicidio.
La mia ansia, che mi ha spinto inizialmente a intraprendere lo sviluppo di uno strumento di valutazione del rischio, è stata chiaramente catturata da uno dei miei ultimi partecipanti, che ha detto perspicacemente come parte di una sessione di feedback: “Mi chiedevo, è un viaggio personale, tu sei Sir Galahad [uno dei cavalieri della Tavola Rotonda] a cavallo per salvare la nazione perché sentivi un tale fallimento in te stesso. E me lo sono chiesto. Non mi sono sentito in alcun modo critico, ho solo sentito, oh, di cosa si tratta? Questo pover’uomo deve dirlo alla nazione, proteggere la nazione…“.
Ha continuato: “Ciò che mi restava era il fatto che era qualcosa di cui eri appassionato… che è uno strano uso delle parole… ma dalla tua esperienza con il tuo cliente, non volevi che nessuno di noi… eri piuttosto protettivo… non volevi che nessuno di noi passasse quello che hai passato tu.”
Quel senso di “fallimento in te stesso” catturava in modo toccante la paura di sbagliare. Come mi disse una volta un terapista, la percezione temuta dagli altri è che “i terapisti abbastanza bravi mantengono in vita i loro clienti“; anche riconoscendo la natura ridicola di questo commento, nel profondo il timore potrebbe essere che sia una verità.
L’importanza del discorso
L’affermazione centrale di questo capitolo riguarda l’importanza fondamentale di una comunicazione efficace con i clienti a rischio di suicidio che trascenda la natura bidimensionale di uno strumento o di un questionario per la valutazione del rischio. La natura esplorativa della comunicazione non solo fornisce la migliore opportunità al professionista – e, cosa più importante, al cliente – di dare un senso in relazione al pensiero suicidario, ma crea anche ulteriori opportunità per un’esplorazione più profonda e aiuta a infondere nel cliente maggiore consapevolezza.
Il discorso, di per sé, non impedirà il suicidio; fornirà tuttavia lo spazio narrativo affinché il suicidio possa essere esplorato in modo significativo.
Rivisitando il lavoro di Schneidman (1998, p**), egli asserisce, “…la strada migliore per comprendere il suicidio non è attraverso lo studio della struttura del cervello, né lo studio delle statistiche sociali, né lo studio delle malattie mentali, ma direttamente attraverso lo studio delle emozioni umane descritte… con le parole della persona potenzialmente suicida. La domanda più importante per una persona potenzialmente suicida non è una domanda sulla storia familiare o sugli esami del sangue o del liquido spinale, ma «dove ti fa male?» e «come posso aiutarti?»“.
Tuttavia, esplorare la domanda “dove ti fa male e come posso aiutarti” non è un’impresa semplice.
Risultati dell’analisi del discorso sul rischio di suicidio
Nella mia analisi del discorso critico (Reeves, Bowl, Wheeler e Guthrie, 2004), sono state analizzate un gran numero di trascrizioni di valutazioni professionista-cliente. I risultati chiave di questo studio sono stati che:
- Il suicidio spesso non viene rivelato esplicitamente dai clienti e in genere se ne parla implicitamente attraverso l’uso di metafore, ad esempio: “Vorrei potermi togliermi di mezzo da tutti”.
- Al primo riferimento al suicidio da parte del cliente, i professionisti – indipendentemente dall’orientamento teorico – tendono a ricorrere a risposte riflessive piuttosto che esplorative, ad esempio: “Quindi sembra che… ho sentito che… stai dicendo che…“.
- L’uso predominante di risposte riflessive a seguito di un riferimento implicito al suicidio da parte di un cliente tipicamente ostacola l’esplorazione, poiché il professionista viene definito nel dialogo dalla posizione del cliente, piuttosto che consentire qualsiasi cambiamento dialogico significativo. Ad esempio, [cliente] “Gira e rigira nella mia testa e non riesco a trovare una via d’uscita“; [professionista] “Ti senti davvero bloccato – continuamente – e non riesci a trovare una via d’uscita“. Sia il cliente che il professionista rimangono bloccati, entrambi definendosi a vicenda e senza trovare una via d’uscita.
- Gli operatori hanno spesso paura di dare un nome al suicidio – di rendere esplicito l’implicito – per paura di “sbagliare” o di mettere il pensiero nella mente del cliente. L’esplorazione esplicita diventa un temuto stimolo al suicidio. Mentre le istituzioni e gli individui forse si ritirano negli strumenti di valutazione del rischio per evitare il relazionale, i professionisti si ritirano nel riflessivo per evitare l’esplorazione.
Questo studio, di per sé ormai un po’ datato, è stato da me replicato (inedito), concentrandosi inoltre sul lavoro con i giovani. Anche con la ricerca intermedia, i risultati erano gli stessi. Evitare una comunicazione aperta sul suicidio con i clienti implica che una serie di responsabilità professionali siano più difficili da soddisfare:
- la gestione adeguata del contratto di riservatezza;
- mantenere il lavoro coerente con le aspettative procedurali dell’organizzazione;
- lavorare in maniera coerente con le aspettative legali ed etiche;
- opportunità mancate per una maggiore esplorazione terapeutica.
Le implicazioni personali sono spesso un aumento del senso di ansia e una maggiore propensione al burnout.
Riflessioni sul lavoro con i clienti
Ricerca a parte, questo capitolo si basa fondamentalmente sulla mia esperienza di lavoro con persone con tendenze suicide, cosa che svolgo da 30 anni. In questo periodo ho sperimentato diversi suicidi di clienti, ognuno dei quali ha avuto un impatto su di me a livello professionale e personale in modo diverso; che vanno da una risposta traumatica precoce che ho sperimentato in seguito alla morte di un cliente per suicidio subito dopo una sessione di consulenza mentre ero tirocinante, fino a un suicidio di fine vita che era stato comunicato dall’individuo a tutti coloro coinvolti nella sua cura.
Offrirò un resoconto di alcuni lavori con un cliente, che chiamerò Jake, per illustrare alcune delle sfide sollevate “in azione”. Dettagli della storia di Jake sono stati modificati (così come il suo nome) per proteggere l’identità.
Presentazione di Jake
Jake ha 19 anni. È ben vestito, eloquente e premuroso. Sta cercando una consulenza, dice, perché si sente uno schifo ed è così da un po’ di tempo. Mi dice che vive con sua madre, che gli è molto solidale, dato che suo padre ha lasciato la casa di famiglia molti anni prima. Vive con la sorella minore ma ora non ha contatti con suo padre. Mi dice che vuole specificamente vedere un terapista uomo perché non ci sono uomini nella sua vita con cui possa parlare.
Prima di vedermi ha compilato un modulo di valutazione, che include domande sul rischio. Ha ottenuto un punteggio pari a zero in termini di rischio, indicando l’assenza di pensieri suicidi e di autolesionismo. Iniziamo la sessione con le presentazioni e invito Jake a raccontarmi la sua storia, cosa che fa. È una triste storia di perdita: dolore e rabbia per il padre scomparso; la morte per incidente di un amico quattro anni prima; e il suo travolgente senso di solitudine, di essere veramente solo nel mondo. Mi dice che anche se ama la sua famiglia, non potrebbe mai parlare dei suoi sentimenti con loro “perché i ragazzi semplicemente non lo fanno, le persone semplicemente non capiscono“. È perso, alla deriva e fatica a trovare le parole.
Prime risposte a Jake
Sono colpito dal paradosso di Jake: qualcuno così forte esteriormente, eppure così giovane dentro e alle prese con un’angoscia travolgente. Inoltre, qualcuno che vuole essere ascoltato, ma a cui è stato insegnato che le parole maschili per esprimere i sentimenti non sono accettabili.
Devo procedere con cautela perché se mi aspetto troppo da lui e troppo presto, potrebbe non tornare. Devo trovare il suo linguaggio e, allo stesso tempo, offrirgli il permesso implicito di parlare di sé. Gli chiedo informazioni su questo modulo di valutazione e noto che, visto come si sente, ha indicato di non avere tendenze suicide. Sono incerto qui, ma mi colpisce anche che in lui potrebbero essere presenti pensieri suicidi. Lui annuisce e dice “Sì, non è un problema per me“. Vorrei essere rassicurato ma non lo sono. Ma ho posto la domanda e, così facendo, spero di aver aperto una porta se mai vorrà attraversarla.
Sessioni successive con Jake
Ci troviamo bene e lui arriva alla seduta successiva e a quelle successive. Ho trovato un umorismo condiviso e ridiamo molto. Mi sento un po’ in colpa se sto colludendo con l’evitamento dei suoi sentimenti, ma la risata sembra relazionale e intima e un ponte attraverso il quale abbiamo trovato un meccanismo per parlarci veramente.
Poi smette di ridere e il contatto visivo si interrompe. Dice che un paio di settimane fa gli ho chiesto del suicidio e lui ha detto che stava bene. Dico sì, ricordo. Dice che non sta bene e pensa spesso al suicidio; sente che non mancherà a nessuno, anche se sa che sarebbe così. Sono tentato di fare riferimento ai suoi punti di forza, ma vedo che Jake ha detto l’indicibile e devo essere coraggioso e restare con questa incertezza.
Riconosco quello che ha detto ma non mi sembra abbastanza. Dico “Quanto hai pensato di ucciderti, Jake? Hai pensato a cosa faresti?” Sembra brutale, fino al punto e so che la parola “uccidersi” non era la sua parola. Ma ricordo anche quanto sia facile non dire le cose difficili e, evitandole, allontanare anche Jake. Metaforicamente trattengo il respiro, chiedendomi se avrei potuto spingerlo a pensare di più, portandolo al limite. Lui dice di no, non è arrivato a questo punto, ma è contento di avermelo detto.
Il fatto che glielo abbia chiesto in modo così diretto all’inizio non gli ha fatto pensare al suicidio, ma gli ha permesso di pensare ai suoi pensieri suicidi. Comincia a piangere e anch’io mi sento terribilmente triste. Parliamo molto di suicidio e sembra che ora la porta sia stata aperta, ora si può parlare di ogni genere di cose. Parla di vergogna, di essere stato precedentemente messo a tacere, di dolore e di non saper vivere, piuttosto che voler morire. Mi colpisce quanto la liberazione e l’annientamento possano spesso coesistere così strettamente insieme.
Ulteriori riflessioni
Jake e io abbiamo lavorato insieme per diversi mesi e, in quel periodo, i suoi pensieri suicidi andavano e venivano, come una terribile marea in cui a volte voleva evitare di bagnarsi, ma in altri momenti aveva bisogno di immergersi. Sarebbe stato così facile fin dall’inizio di non aver chiesto a Jake del suicidio. Ma ricordo anche a me stesso che spesso è compito del professionista dare un nome alle cose difficili, sapendo che sarà il cliente a decidere se andarci oppure no.
Mi viene anche in mente il grande mito del suicidio: che chiedendolo potremmo stimolare il pensiero nella mente dell’altro. So che non è così, in quanto chiedere del suicidio, nella peggiore delle ipotesi, lascerà invariato il livello di rischio. Nella migliore delle ipotesi, offrirà l’opportunità di parlarne e, così facendo, il rischio di agire in base ai pensieri può essere ridotto. Mi è stato inoltre ricordato che non esiste un “tipo” suicidario, ovvero una persona che più probabilmente porrà fine alla propria vita. Piuttosto, nei momenti di crisi o disperazione, tutti abbiamo questo potenziale.
Affrontare il rischio di suicidio: indicatori di buone pratiche
Mettendo insieme i fili di questo capitolo, siamo in grado di identificare alcuni indicatori chiave di buone pratiche che possono supportare la nostra comunicazione con le persone a rischio di suicidio. Per ribadire, l’approccio basato su questionari per la valutazione del rischio di suicidio non è del tutto negativo: tali strumenti possono essere utili, ma in generale nel fornire una struttura attraverso la quale il dialogo può essere avviato ed esplorato.
L’affermazione qui, e riflettendo sulle conclusioni di Large et al (2016), è che gli strumenti di valutazione del rischio non offriranno ciò che speriamo da loro: una risposta definitiva, o addirittura una buona indicazione, del fatto che qualcuno sia a rischio di suicidio. Si torna sempre al dialogo e al modo in cui possiamo sostenerci nel processo relazionale di comunicazione.
I seguenti consigli pratici per migliorare la comunicazione con le persone a rischio di suicidio sono, in parte, direttamente collegati al discorso e, in parte, legati ai fattori che sostengono il discorso. Nel lavorare con il potenziale suicidario, la comunicazione non avviene nel vuoto: i fattori professionali e personali discussi in precedenza devono essere affrontati in modo completo, attento e con la dovuta riflessione per garantire che il discorso sia diretto, chiaro, rispettoso, onesto, empatico e onori il natura della relazione di aiuto.
Consigli pratici per migliorare la comunicazione
- Comprendere le regole e le aspettative del contesto.
- Contrattare con attenzione e chiarezza, facendo chiaro riferimento al suicidio considerando il suo potenziale nel contesto della narrativa del cliente.
- È importante conoscere i gruppi a rischio più elevato, ma queste informazioni informano solo il dialogo, piuttosto che rispondere alle domande.
- Conoscere i segnali di pericolo
- Essere in grado di identificare i fattori protettivi e aiutare il cliente a nominarli.
- Essere disposti ad esplorare attraverso domande aperte e dirette: “Hai mai pensato di farti del male quando soffri, o hai pensieri di non voler più essere vivo?“.
- Bilanciare sia i fattori di rischio che quelli protettivi.
- Discutere con il supervisore/colleghi/manager, ove appropriato.
- Registrare attentamente preoccupazioni e azioni.
- Ottenere il consenso, ove possibile, se è necessario discutere le tue preoccupazioni con qualcun altro.
- In caso di dubbi sulla sicurezza immediata, agire.
Articolo liberamente tradotto e adattato. Fonte: Reeves, A. (2021). Exploring the ‘talk’ of suicide: Using discourseinformed approaches in exploring suicide risk. In M. O’Reilly & J. N. Lester (Eds.), Improving communication in mental health settings (pp. 175-190). London, United Kingdom: Routledge.